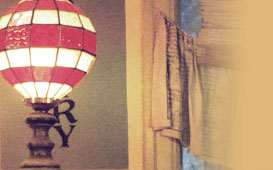Mille, mille e cento metri
Mustafa ci fa riconoscere il viale dei cecchini che abbiamo percorso qualche ora prima e poi fa un gesto con la mano, ne cambia l’inclinazione rendendo più acuto l’angolo che unisce il suo corpo a quello della città che sta lì sotto. Guardate, dice: secondo voi quanto è distante? Non dice a cosa si sta riferendo, ma gli occhi e il dito puntano verso il ponte e Terezje, uno dei viali che costeggia la riva sinistra del fiume. Andrew fa subito un gesto con le spalle come per dire amico, sono qui perché me lo dica tu; io ci provo ma butto un numero a caso come quando una signora del British Museum mi mise in mano un pezzo di selce che mi aveva spiegato essere un utensile da cucina preistorico e mi chiese secondo me quanto poteva essere antico (dissi sei-settemila, lei rise bonaria e mi informò che sarebbe stato meglio se avessi stretto un po’ di più la presa, perché quel sasso aveva quattrocentomila anni di età), tento quasi più per far piacere a Mustafa che per cercare di dare una risposta giusta perché con le misurazioni a occhio non sono mai stato un granché, non so stimare una distanza, un’altezza, un peso. Non credo che Mustafa mi ascolti, e d’altra parte come dargli torto: tiene lo sguardo verso la città e dice, come se parlasse a se stesso: “mille, mille e cento”. Lo guardo perché d’acchito non capisco di cosa parla. “Da qui al fiume sono mille metri, mille e cento al massimo”, continua, e spiega che era la gittata massima dei fucili di precisione usati dai cecchini serbi, oltre la quale anche soggetti molto ben addestrati come quelli non potevano garantire l’accuratezza del tiro. Ma mille, mille e cento metri era la distanza giusta, potevano colpire chi volevano, in qualunque momento. Quindi stavano qui, avevano qui una postazione? gli chiediamo e lui con l’altra mano indica un punto indistinto che sta più o meno alle nostre spalle, a qualche metro di altezza sopra le nostre teste. Non posso parlare per Andrew ma io riesco solo a vedere una macchia di cespugli e nulla che faccia immaginare una possibile disposizione di uomini e armi. “Quel sasso”, dice Mustafa, “quello bianco che vedete lì”, circa a metà del cespuglio, lo dice con la stessa ostinata urgenza che ha usato quando si è incaponito a farci individuare il palazzo vicino all’aeroporto nel quale viveva con i genitori e il fratello quando iniziò l’assedio; e quando capiamo di cosa sta parlando, a cosa si sta riferendo non possiamo evitare di mostrargli il nostro perplesso stupore perché quello che ci sta mostrando è uno spuntone calcareo che sarà largo un metro e lungo forse due, una cosa che esce dal profilo della collina come un naso coperto di rami e foglie e ci rifiutiamo di credere che un uomo potesse passare abbarbicato lì sopra anche solo dieci minuti, figuriamoci le ore di immobilità che fanno parte integrante del lavoro di un cecchino in tempo di guerra. E invece Mustafa ci conferma che chi era di turno stava proprio lì, che la posizione era scomoda ma perfetta per copertura e visuale.
Riporta lo sguardo verso il basso, verso la città e il fiume che la attraversa: “erano bravi i serbi”, dice, e mi pare di sentire nella sua voce l’inevitabile e insopprimibile e paradossale ammirazione che una persona buona e onesta prova nei confronti di chi fa bene il suo lavoro anche se questo consiste nello sparare a un innocente che sta andando a comprare il pane. E’ un riconoscimento che viene da lontanissimo, dai nostri avi, dalla scuola, da un modo di stare al mondo che per arrivare a definire l’orrore deve fare una mezza dozzina di passi di razionalizzazione, prima dei quali sta la spontanea ammirazione per la combinazione di capacità e applicazione che rende alcuni soggetti speciali e li fa spiccare nel loro perimetro di competenza, sia questo il campo di calcio per Messi o la creazione e gestione del sistema di trasporto verso i campi di sterminio per Eichmann. Erano estremamente ben addestrati, dice Mustafa guardando verso il fiume, non sbagliavano mai. Ferivano se volevano ferire, uccidevano se volevano uccidere. Tu conoscevi la loro posizione, quello che non sapevi e non potevi sapere era quando avrebbero deciso di sparare, quando ne avrebbero avuto voglia o ricevuto l’ordine. Fissiamo la Miljacka e il ponte e quel pezzetto di Sniper Alley che si può vedere dallo spiazzo nel quale Mustafa ci ha raccontato la storia di un cecchino e delle sue vittime con un’assenza di enfasi così evidente da renderla addirittura tangibile e per un momento, che non ho idea di quanto sia durato, restiamo in silenzio, lui a ricordare e noi a immaginare sapendo di non poterci riuscire, non davvero. Con un mezzo sorriso Mustafa ci dice che è ora di andare, di tornare a Sarajevo e noi ci avviamo verso la macchina, buttando un ultimo sguardo verso lo spuntone di pietra sul quale si sdraiava il cecchino, che chissà se gli veniva mai mal di schiena, se gli capitava di tremare per il freddo e sudare per il caldo, se provava piacere a sparare, se si pisciava addosso a tre quarti di un turno, che chissà chi era e che faccia aveva.
A me non fa né caldo né freddo sapere che ci sono stati cento, duecento, mille italiani che hanno pagato per andare a tirare sui sarajevesi che cercavano di sopravvivere un altro giorno: se se ne vuole fare una questione contabile allora si deve ricordare che ce ne sono stati migliaia – decine, centinaia di migliaia – che per la Bosnia hanno fatto tutto il bene possibile, e continuano a farlo oggi. Il punto non è quello, non può e non deve essere quello, il punto è chi, cosa sei se ti va di aprire il portafogli per provare ad ammazzare uno sconosciuto inerme che sta a mille, mille e cento metri di distanza.